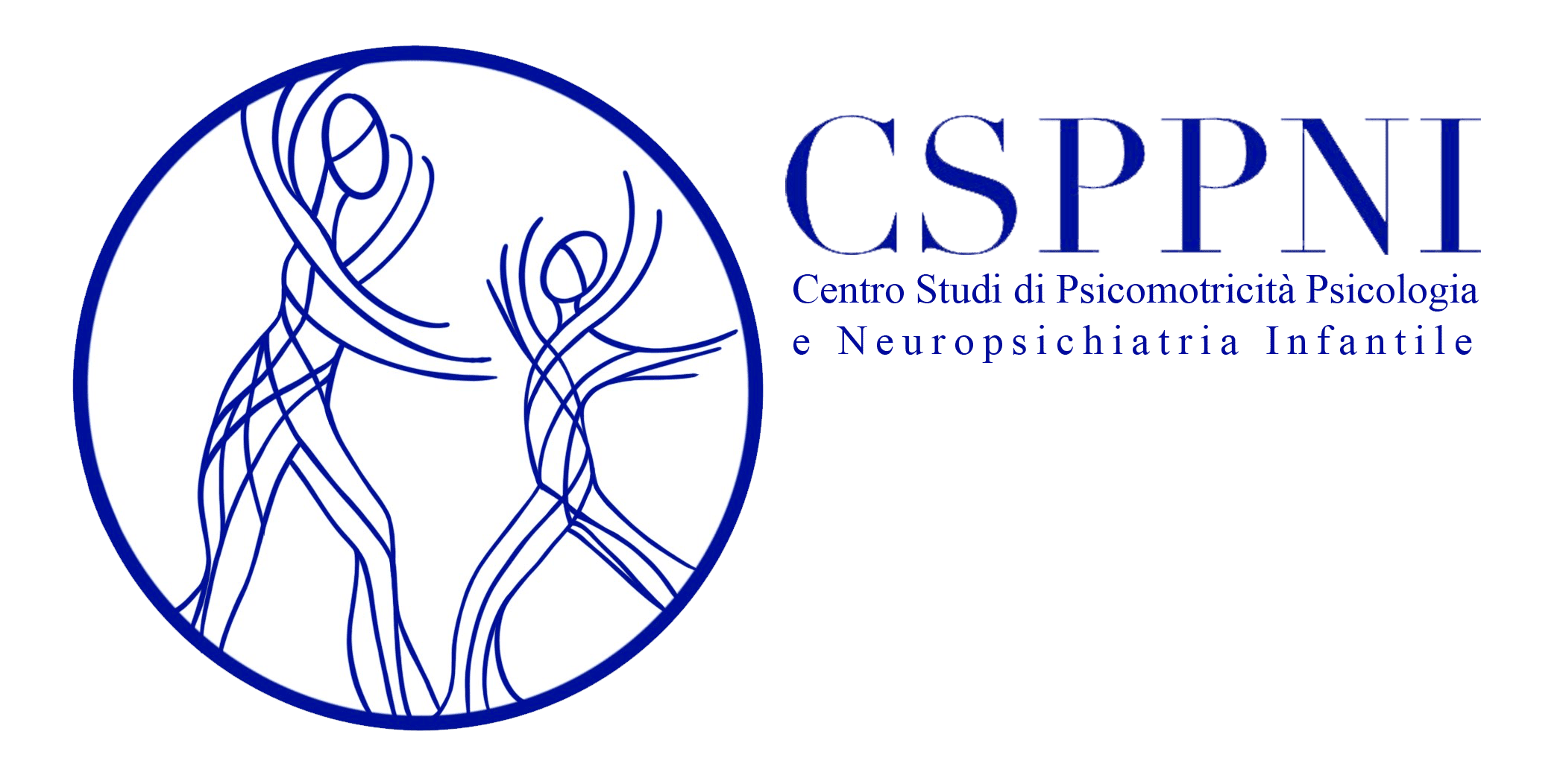Stress evolutivo o evoluzione autistica?
Valutazione e intervento nella sintomatologia di tipo autistico
in fase di stampa, disponibile a breve
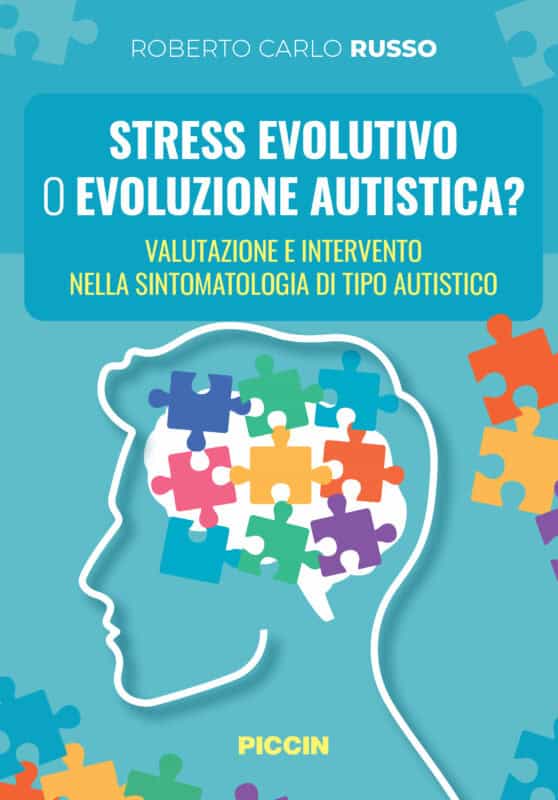
Il dato importante e significativo messo in risalto dall’Autore nella fascia 12-36 mesi è la possibilità di una problematica evolutiva, nominata Stress Evolutivo, da varia genesi (disfunzioni di alcune competenze neurologiche, ricoveri prolungati, cambio della struttura familiare, carenze affettive o inadeguati metodi educativi) tale da determinare nel bambino una modalità comportamentale sostenuta da uno stato confusivo e di sconcerto per l’incapacità di reperire una via di sviluppo della propria carica evolutiva; ne consegue la chiusura (completa o parziale) al rapporto di comunicazione con l’altro e la possibile sua sostituzione con gli oggetti e le auto-stimolazioni. Il bambino resta in attesa di un indirizzo evolutivo per superare la difficoltà.
Sia che il problema dipenda da carenze neurofunzionali, genetiche o ambientali, viene confermata la necessità che i modelli genitoriali e scolastici debbano essere aiutati a comprendere le difficoltà e a dare gli stimoli appropriati per sostenere la spinta evolutiva.
La proposta innovativa per il superamento della problematica, oltre a basarsi su una corretta diagnosi, richiede un intervento precoce al bambino (terapia a mediazione corporea) e una frequenza assidua di competenti stimoli evolutivi e adeguato rapporto di aiuto ai genitoriali e alle figure scolastiche.
L’intervento precoce e competente favorisce la progressione dello sviluppo (in rapporto all’entità delle cause) anche verso una completa o parziale risoluzione. Frequentemente se gli effetti della genesi non sono gravi e non ancora strutturati può essere risolutivo solo il supporto parentale e scolastico con il risparmio di tutti gli effetti negativi dell’etichetta, della sofferenza familiare e della non sotto valutabile spesa economica.
L’impostazione con l’ottica globale del problema permette di considerare che spesso il comportamento del bambino rappresenta solo il sintomo di una situazione di malessere ambientale; in alcuni casi la disponibilità parentale ad affrontare la genesi delle dinamiche e a modificare i codici educativi ha permesso di ottenere ottimi risultati (Russo, 1997, 2018).
Articoli di Roberto Carlo Russo
Elenco degli articoli pubblicati
Patologie Neuropsichiatriche Infantili
ADHD o Instabilità Psicomotoria
ADHD (Attention Deficit Hyperacttvity Desorder) o Instabilità Psicomotoria di Roberto Carlo Russo
Per definire un bambino con grande quantità di attività motoria i termini “instabile psicomotorio” e”ipercinetico” risultano quelli più diffusi e sicuramente più usati col significato di sindrome…
Allattamento a richiesta: biologia e processo di separazione-individuazione
La nascita è il primo passo del lungo processo di separazione: la separazione fisica dal corpo della madre, ma il bambino, abituato nel periodo gestazionale ad una unità inscindibile «Sé-madre», nonostante la separazione fisica vive ancora l’unione tra il Sé ed il non Sé (madre). La madre che ha rappresentato la fonte di vita
Attaccamento
Donald Woods Winnicott (1965) ha segnalato l’importanza e relativi effetti della Deprivazione Materna della Care nel corso del primo anno. Per una sana evoluzione Winnicott ha dato importanza a tre competenze materne: holding (contenimento), handling (manipolazione), object presenting (presentazione della realtà tramite gli oggetti e ha affermato che …..
Attività motorie specifiche (lancio, calcio, salto)
Le attività che il bambino usa di frequente nel gioco motorio con i coetanei o con l’adulto, permettono una specifica valutazione delle reali competenze motorie. Il loro studio ha portato ricche informazioni: uso degli schemi, loro coordinamento, velocità esecutiva, precisione del risultato, adeguamento della forza applicata …….
Autismo: Stress Evolutivo o Evoluzione Autistica?
Alle sindromi autistiche appartengono tutte quelle forme in cui il nucleo patogenetico, agente nei primi tre anni di vita, è costituito da un grave disturbo della comunicazione sostenuta da diverse cause ipotizzate: fattori organici, mutazioni genetiche, alterazioni metaboliche, carenze neurofunzionali, inadeguati modelli di riferimento, fattori ambientali che condizionano una difficoltà da parte dei modelli (anche potenzialmente adeguati) di rapportarsi alle caratteristiche neurobiologiche che si differenziano da una norma evolutiva.
Bisogni evolutivi del Bambino
Il comportamento del bambino è frutto di un lungo evolvere che, partendo da una base biologica, interagisce con le condizioni socio-culturali dell’ambiente in cui vive. L’adattamento comportamentale del bambino deve prendere in considerazione il fenomeno in atto e rapportarlo alle caratteristiche specie-specifiche ……
Condizionamenti sociali nel bambino
Dinamiche emozionali dell’atto motorio
Wallon (1932, 1956) nella sua pubblicazione sulle sindromi da insufficienza dell’organizzazione psicomotoria e sulle tipologie psicomotorie, ha dato importanza alla stretta correlazione tra il tono muscolare e le caratteristiche dell’individuo e relative variabili in rapporto alle situazioni…
Disgrafie
La scrittura è uno strumento di comunicazione scritta del lessico tramite una serie di segni convenzionali specifici e riconoscibili che vengono appresi tramite due modalità: una spontanea per gli stimoli apportati dalle immagini delle insegne pubblicitarie,
della stampa e della televisione…
Disprassia Evolutiva
Lo studio dell’evoluzione e organizzazione degli schemi motori nel bambino, con tutte le loro variabili che vanno dalla norma, alla variante della norma e alla patologia, vengono spesso non sufficientemente approfondite, valutate e considerate nella loro espressività ludica e in rapporto a differenti tipi di organizzazione motoria…
Disturbi Motori
Da questo gruppo di disturbi riteniamo importante non includere e differenziare numerose patologie neuropsichiche nelle quali il tipo di lesione o malformazione o disfunzione del sistema nervoso centrale definisce in modo specifico il morbo o la sindrome stessa…
Evoluzione dei processi attentivi
Una condizione essenziale per l=individuo umano e comune a tutti gli animali, è la possibilità di valutare gli stimoli ambientali per potere scegliere il comportamento più adeguato alla situazione in base alle proprie esperienze…
Evoluzione dell’Atto Motorio
La progressione degli infiniti atti motori possibili si realizza in tre livelli evolutivi: il coordinamento, il processo di inibizione alla diffusione dello stimolo e l’integrazione somatica …….
Gioco Simbolico e Produzione Fantasmatica in terapia psicomotoria
Winnicott è l’autore che ha portato nuove concezioni sui significati del gioco simbolico, affermando e sottolineando l’importanza di “quell’area intermedia” dove ciascun individuo può “giocare” le proprie progettualità…
Il significato dell’intervento psicomotorio e il setting
La diagnosi e la terapia vanno affrontate nell’ottica del problema bambino-ambiente, l’intervento infantile impostato in un’ottica centrata esclusivamente sul bambino ha fatto il suo tempo dal punto di vista scientifico…
Il supporto ai modelli di riferimento evolutivo
Nei nostri servizi frequentemente risulta difficile agganciare in modo sufficientemente
efficiente le figure genitoriali per sensibilizzarle all’inizio di una terapia per il bambino e alla
necessità di un loro supporto per i problemi educativi…
Insufficiente Inibizione Motoria
La progressione degli infiniti atti motori possibili si realizza in tre livelli evolutivi: il
coordinamento, il processo di inibizione alla diffusione dello stimolo e l’integrazione somatica…
Maldestrezza
Nel corso evolutivo l’apprendimento di nuovi schemi motori, assume il significato di rendere sempre più vantaggiosa e competitiva la propria attività…
Modelli evolutivi
L’analisi dei fattori elencati personali e sociali dei modelli, ci avverte della complessità di questa valutazione, pertanto, pur cosciente delle difficoltà, ho ritenuto importante procedere nella ricerca, prevedendone i limiti e la complessità e, ben lungi da volere etichettare e colpevolizzare le figure, solo sostenuto dallo studio per la conoscenza …..
Orientamento della personalità infantile
I risultati dell’interrelazione tra le caratteristiche di un genitore e le risposte comportamentali del bambino mi hanno stimolato a ricercare le tipologie di orientamento della personalità infantile di più frequente riscontro…
Sindromi d’interesse psicomotorio
Mi sembra indispensabile far precedere alla trattazione della patologia la definizione di quel periodo di vita che possiamo chiamare psicomotorio, in cui le modalità di essere dell’individuo sono dominate da un’unicità espressiva di stati e livelli emozionali e di comportamenti motori…
Processo di lateralizzazione e dislateralizzazione
La ricercatrice australiana Lesley Rogers (1970), studiando i polli ha scoperto che la lateralizzazione è comune a tutto il regno animale. Altri autori hanno riscontrato nei mammiferi la predominanza d’interesse visivo di un emi-spazio rispetto al controlaterale…
Sindrome da Scarsa Fiducia del Sé
È frequente il riscontro, di norma all’inizio delle elementari, di segnalazioni da parte degli insegnanti di bambini timidi, particolarmente riservati, richiedenti eccessivo aiuto, che tendono a perdersi per modeste difficoltà e…
Storia della Psicomotricità
Questa relazione si basa in parte sulla pubblicazione del 2001 frutto di un approfondito studio fatto dal Dr. Franco Boscaini sulla genesi della Psicomotricità
Learn MoreNeurofeedback Neuroptimal
Neurofeedback Dinamico non lineare NeurOptimal®
Il neurofeedback dinamico non lineare NeurOptimal® è uno strumento di benessere (non un dispositivo medico) che allena il cervello a funzionare in maniera ottimale, facilitando nuovi processi adattivi.
La vita che si conduce, spesso costellata da situazioni stressanti, sfide, difficoltà lavorative e scolastiche ma anche complesse situazioni relazionali, ci porta in maniera difensiva ad attivare meccanismi che inizialmente sono utili per gestire le situazioni nell’emergenza, ma nel lungo periodo si dimostrano non più efficaci ad affrontare gli eventi della vita. Ci si trova bloccati e irrigiditi in situazioni dalle quali non si riesce ad uscire, incapaci di riattivare le proprie risorse.
 NeurOptimal® fornisce un training che stimola il cervello in modo naturale, non invasivo e senza effetti collaterali ad essere più presente e più efficace in ogni momento, stimolando funzioni cerebrali sane e riattivando le nostre capacità.
NeurOptimal® fornisce un training che stimola il cervello in modo naturale, non invasivo e senza effetti collaterali ad essere più presente e più efficace in ogni momento, stimolando funzioni cerebrali sane e riattivando le nostre capacità.
L’effetto è una mente più aperta, positiva e flessibile, in cui gli ostacoli e i problemi sono più gestibili poiché si è allenato il cervello a sfruttare il proprio potenziale in maniera maggiormente integrata.
Questo allenamento porta ad una miglior gestione dello stress, all’aumento del benessere psicofisico, delle abilità e delle performance di adulti, adolescenti e bambini.
COME FUNZIONA?
La persona durante una sessione di neurofeedback è seduta comodamente su una poltrona, con dei sensori posizionati sul cuoio capelluto, mentre ascolta della musica rilassante.
Il Neurofeedback Dinamico Neuroptimal® allena il funzionamento cerebrale ad auto-regolarsi attraverso l’udito. La musica e alcune sue brevi interruzioni sono i vettori mediante i quali il software agisce.
 Il nostro cervello produce un’attività elettrica che viene rilevata da questi sensori e visualizzata su un monitor in tempo reale come se osservassimo ad uno specchio le variazioni della nostra attività e utilizzassimo tali informazioni per modificarle a nostro personale vantaggio e soggettivo benessere.
Il nostro cervello produce un’attività elettrica che viene rilevata da questi sensori e visualizzata su un monitor in tempo reale come se osservassimo ad uno specchio le variazioni della nostra attività e utilizzassimo tali informazioni per modificarle a nostro personale vantaggio e soggettivo benessere.
Grazie ad uno specifico algoritmo, il software NeurOptimal® analizza le informazioni ed individua quelli che vengono chiamati: eccessi di variabilità interna e li segnala attraverso l’interruzione della musica che la persona sta ascoltando. Essendo l’individuo umano molto sensibile alla coerenza della melodia, l’interruzione viene percepita come qualcosa che disattende le aspettative. Quindi questo segnale diventa un feedback che informa il cervello di una sua eccedenza, stimolandolo gradualmente a riorganizzarsi. Questo porta a una diminuzione degli eccessi di variabilità interna e favorisce un processo di autoregolazione che aumentando la flessibilità.
PERCHE’ UTILIZZARLO?
Per migliorare:
- La qualità della vita, le prestazioni, la padronanza e la sicurezza in ambito lavorative, scolastico, sportivo e artistico
- La gestione dello stress e il rilassamento
- Gli stati di affaticamento e stanchezza
- La gestione del sonno
- La proattività, la flessibilità, l’attenzione e l’autostima
- Il livello di apprendimento, concentrazione, risoluzione dei problemi
CHI PUO’ USARLO?
 Il Neurofeedback Dinamico non lineare Neuroptimal®, può essere usato ad ogni età e non ci sono patologie interferenti all’utilizzo.
Il Neurofeedback Dinamico non lineare Neuroptimal®, può essere usato ad ogni età e non ci sono patologie interferenti all’utilizzo.
Il neurofeedback dinamico non lineare è riconosciuto (Ottobre 2018) dalla Food and Drug Administration americana come “general wellness”, cioè come generale strumento di benessere.
Learn More